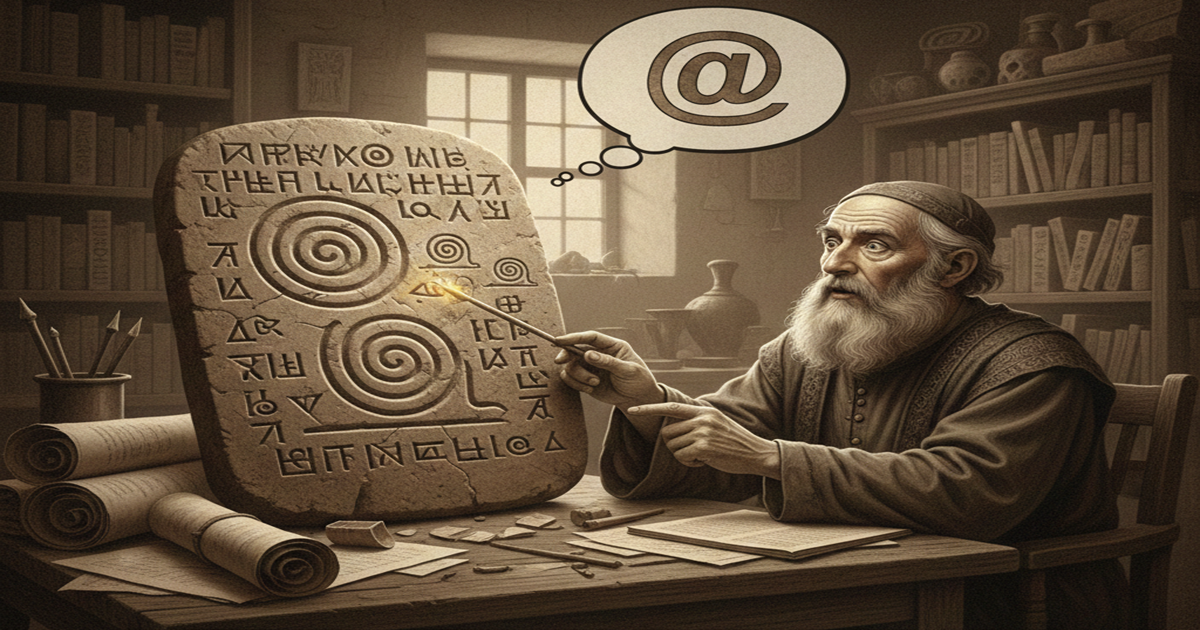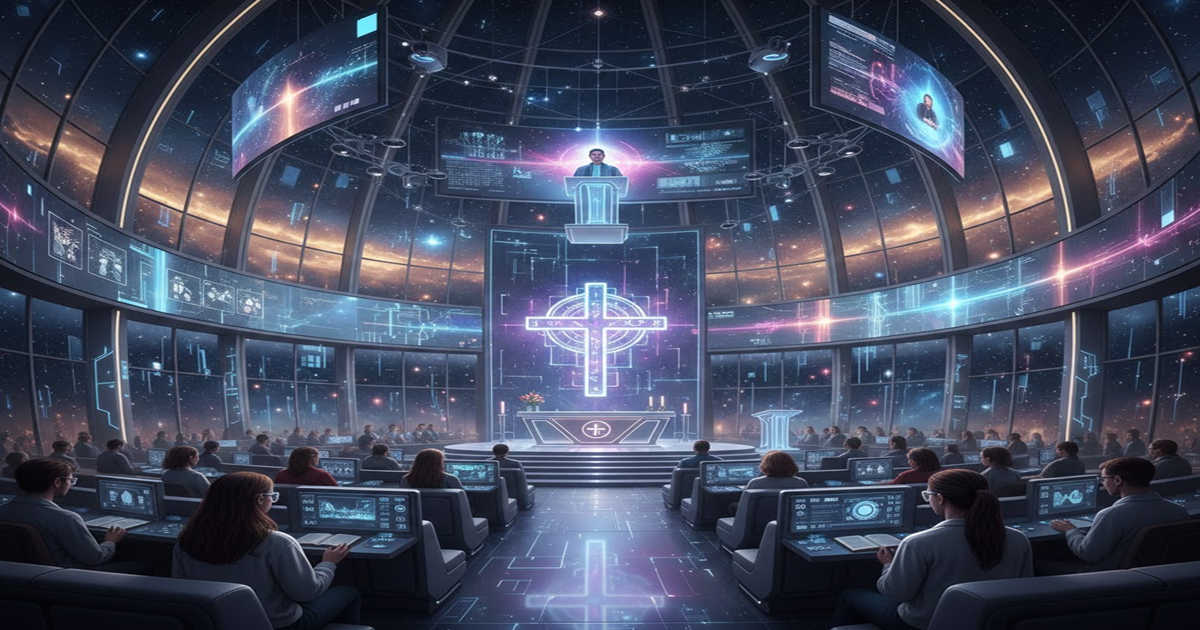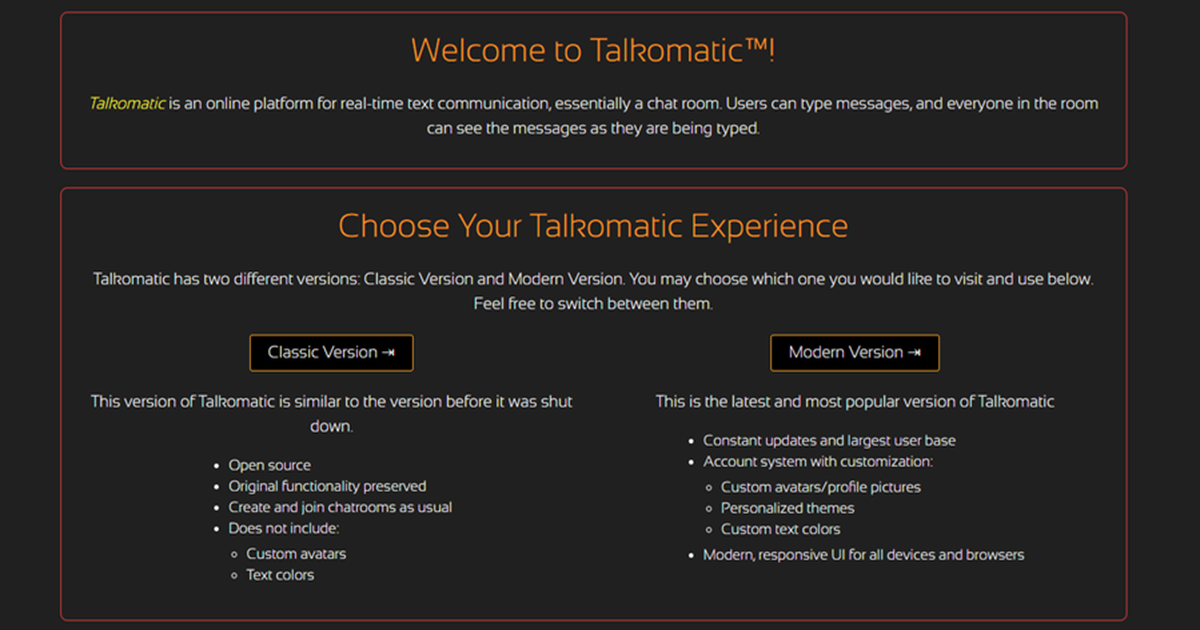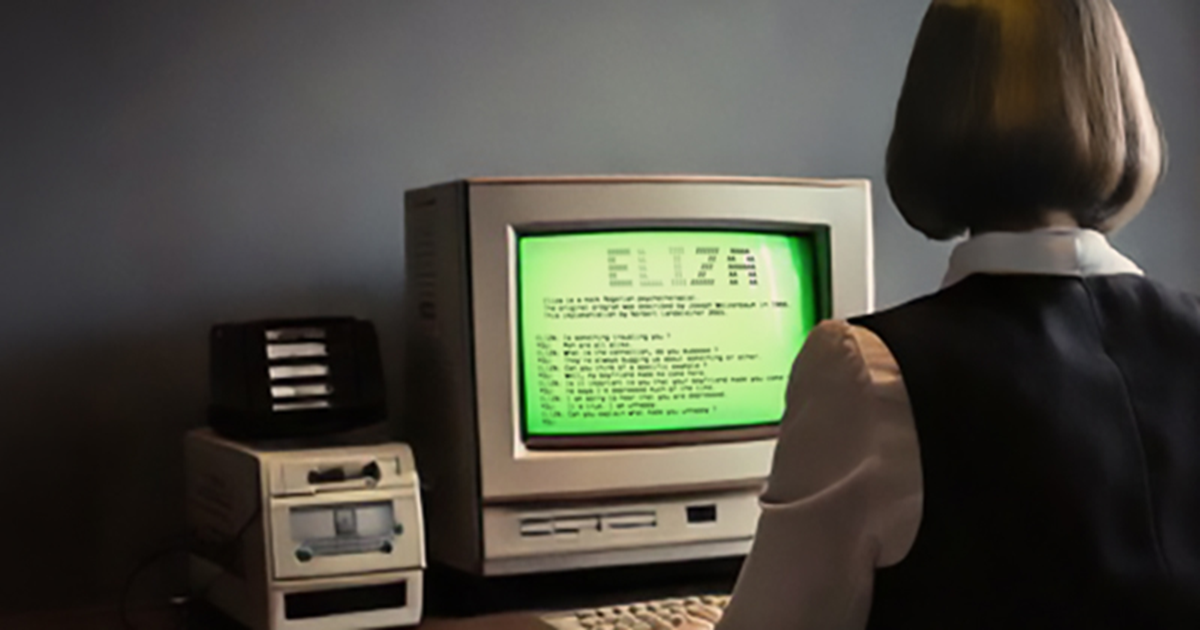Haters: ovvero gli "odiatori" sul web e sui social

Attenzione a diffondere l'odio su internet. I cosiddetti "haters" ovvero gli "odiatori" che imperversano sul web e sui social, commentando e contestando con modalità aggressive, violente e offensive, rischiano serie conseguenze secondo le vigenti norme di legge.
Haters: chi sono
Il neologismo "haters" è utilizzato in Internet per identificare quei soggetti che, sul web o attraverso i social, manifestano atteggiamenti di odio, disprezzo e critiche che dovente sconfinano in vere e proprie offese (ad esempio di genere o di classe) e/o minacce rivolte ad altri utenti o nei confronti di personaggi più o meno noti.
Questi "leoni da tastiera", che quotidianamente riversano rabbia e odio verso gli altri su Internet, si trincerano dietro lo schermo del PC o dello smartphone, utilizzati come scudo con la convinzione che quanto accade o viene commesso nell'ambiente virtuale non abbia conseguenze o ricadute nella vita quotidiana "reale".
Ma il sentirsi invincibili è un grave errore, poiché il virtuale altro non è che una proiezione del reale, dietro cui ci sono persone vere e conseguenze serie poiché il web non rappresenta affatto una zona franca avulsa da ogni ripercussione. In sostanza, ciò che avviene su internet o sui social, tramite una connessione senza cavi, può avere serie e tangibili conseguenze.
In particolare, la legge trova applicazione nei confronti delle condotte poste in essere tramite internet e sovente la giurisprudenza è intervenuta a confermare che l'offesa e la denigrazione attuate sui social network o sul web hanno conseguenze anche penali. E non sarà possibile invocare a propria difesa la libertà di espressione poiché la legge non prevede sconti nei confronti chi diffonde l'odio.
Sono diversi i reati di cui comunemente può macchiarsi un hater: si va dalla diffamazione aggravata alle minacce o molestie, fino addirittura all'incitamento allodio razziale allo stalking.
Offese sui social network: ecco i rischi
Esprimere un pensiero o un'opinione, ad esempio, può costare una condanna per diffamazione, se ciò avviene con modalità lesive dell'altrui dignità, ignorando buon senso e correttezza.
Infatti, nonostante la libertà di espressione del pensiero sia costituzionalmente tutelata (ex art. 21 Cost.), ciò non significa che questa non abbia dei limiti e che possa operare sempre e comunque come scriminante. La critica, anche particolarmente aspra e forte, dovrà essere pertinente al fatto (dunque non generalista) e soprattutto continente.
In particolare, secondo la giurisprudenza, il limite della continenza nel diritto di critica è superato in presenza di espressioni che, in quanto gravemente infamanti e inutilmente umilianti, trasmodino in una mera aggressione verbale del soggetto criticato. In sostanza, non si potrà in alcun modo scriminare l'uso di espressioni che si risolvano nella denigrazione della persona di quest'ultimo in quanto tale (cfr. ex multis, Cass. n. 11409/2015).
Haters e diffamazione
Uno degli atteggiamenti più diffusi da parte degli "haters" è proprio quello di rivolgersi agli altri utenti utilizzando frasi volutamente offensive e spesso addirittura diffamatorie. Parole usate talvolta con una eccessiva leggerezza, che sono idonee a far scattare la responsabilità penale degli autori e il conseguente obbligo di risarcire il danno prodotto.
L'art. 595 del codice penale punisce con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 1032 euro, chiunque "comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione". Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è quella della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a 2065 euro.
In particolare, un linguaggio dispregiativo che si traduca in offese su internet alla reputazione altrui possono costare un'incriminazione per diffamazione aggravata. Il codice penale precisa che "se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a 516 euro".
La diffamazione aggravata sui social network
La giurisprudenza, compresa quella di legittimità ha confermato il pugno duro contro coloro che utilizzano internet, e i social network in particolare, come una valvola di sfogo per scaricare rabbia, frustrazioni o sete di vendetta nei confronti di personaggi pubblici, ma anche conoscenti, colleghi o capi.
Ad esempio, si è giunti alla conclusione che anche la diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l'uso di una bacheca Facebook integra un'ipotesi di diffamazione aggravata, poiché ha potenzialmente la capacità di raggiungere un numero indeterminato di persone.
Ciò in quanto, per comune esperienza, bacheche di tal natura racchiudono un numero apprezzabile di persone e, inoltre, perché l'utilizzo di Facebook integra una delle modalità attraverso le quali gruppi di soggetti socializzano le rispettive esperienze di vita, valorizzando in primo luogo il rapporto interpersonale, che, proprio per il mezzo utilizzato, assume il profilo del rapporto interpersonale allargato ad un gruppo indeterminato di aderenti al fine di una costante socializzazione (cfr. Cass., n. 8328/2016).
Secondo parte della giurisprudenza, il reato può scattare anche nei confronti di chi semplicemente aggiunge al post originale un successivo commento, avente la medesima portata offensiva, in quanto elementi diffamatori aggiunti possono comportare una maggior diminuzione della reputazione della nella considerazione dei consociati (cfr. Trib. Campobasso, sent. n. 396/2017).
Sarà utile per il denunciante che vuole dimostrare l'avvenuta consumazione del reato munirsi di uno screenshot dello schermo, o anche di un video, nonché di testimonianze di coloro che hanno potuto leggere il contenuto del messaggio diffamatorio.
Nonostante il colpevole possa confidare in un'assoluzione per "particolare tenuità del fatto", qualora il giudice ritenga non gravi le conseguenze del suo comportamento, rimane comunque la possibilità per la vittima, lesa nel proprio onore e nella propria reputazione, di chiedere il risarcimento del danno in via civile.
Haters: attenzione alle minacce
Gli Haters rischiano anche di incorrere in altri reati, ad esempio quello di minaccia qualora dovesse prospettare ad altri la conseguenza di una propria credibile azione pericolosa (es. "Ti farò fare una brutta figura", "Ti vengo a prendere", "Ti uccido" ecc.).
Il codice penale punisce, a querela della persona offesa, chiunque minacci ad altri un danno ingiusto. La pena è quella della multa fino a euro 1.032. Qualora la minaccia sia grave o aggravata ex art. 339 c.p., la pena è della reclusione fino a un anno.
Il reato di molestie
Anche il reato di molestie può essere realizzato tramite internet e i social network. Questi ultimi, si rammenta, sono considerati ormai dalla giurisprudenza come luoghi aperti al pubblico a tutti gli effetti. In particolare, per la Cassazione (cfr. sent. n. 37596/2014) tale nozione andrebbe interpretata in modo estensivo: il social network, infatti, consente un numero indeterminato di accessi e visioni, rese possibili da un'evoluzione scientifica che il legislatore non era arrivato ad immaginare.
Ben può trovare applicazione, dunque, l'art. 660 c.p. che punisce chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo. La pena è quella dell'arresto fino a sei mesi o l'ammenda fino a 516 euro.
Cyberstalking
Le critiche dell'hater possono dunque portare all'incriminazione quando, pur essendo espresse in forma pacata e dunque lecita, siano divenute assillanti e ripetitive, e addirittura possono far scattare il reato di stalking che ormai la giurisprudenza sempre più spesso ritiene perpetrabile tramite i social network.
Le condotte, per essere incriminabili, dovranno aver procurato un evento di danno o di pericolo (alterazione delle abitudini di vita o perdurante grave stato di ansia o paura), essersi realizzate in fasi o momenti sufficientemente determinati ed essere prese in considerazione come componenti della condotta persecutoria nel suo complesso.
Nella sentenza n. 21407/2016 gli Ermellini hanno anche precisato che, ai fini dello stalking, rileva la reiterazione delle condotte, non l'episodio singolo, che anche se integrabile un reato autonomo, deve essere letto nell'ambito delle attività persecutorie nel loro complesso.
I crimini d'odio
Gli "haters", con i loro atteggiamenti, rischiano anche di incorrere nei c.d. crimini d'odio, dall'inglese "hate crimes", i quali ricomprendono gli atti di rilevanza penale che hanno alla base un movente discriminatorio, in relazione all'appartenenza (vera o presunta) a un gruppo sociale, identificato in base a etnia, religione, orientamento sessuale, dell'identità di genere o di particolari condizioni fisiche o psichiche.
La legge Mancino, n. 205/1993, sanziona proprio gesti, azioni e slogan aventi per scopo l'incitazione alla violenza e alla discriminazione per motivi razziali, etnici, religiosi o nazionali.
In particolare, rischia la reclusione fino a un anno e sei mesi o una multa fino a 6mila euro chiunque faccia propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, oppure istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.
La pena diventa il carcere da 6 mesi a 4 anni per chi invece istiga, con qualunque modalità, a commettere o commette atti di violenza o di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.
© 𝗯𝘆 𝗔𝗻𝘁𝗼𝗻𝗲𝗹𝗹𝗼 𝗖𝗮𝗺𝗶𝗹𝗼𝘁𝘁𝗼
Tutti i diritti riservati | All rights reserved
Informazioni Legali
I testi, le informazioni e gli altri dati pubblicati in questo sito nonché i link ad altri siti presenti sul web hanno esclusivamente scopo informativo e non assumono alcun carattere di ufficialità.
Non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori od omissioni di qualsiasi tipo e per qualunque tipo di danno diretto, indiretto o accidentale derivante dalla lettura o dall'impiego delle informazioni pubblicate, o di qualsiasi forma di contenuto presente nel sito o per l'accesso o l'uso del materiale contenuto in altri siti.