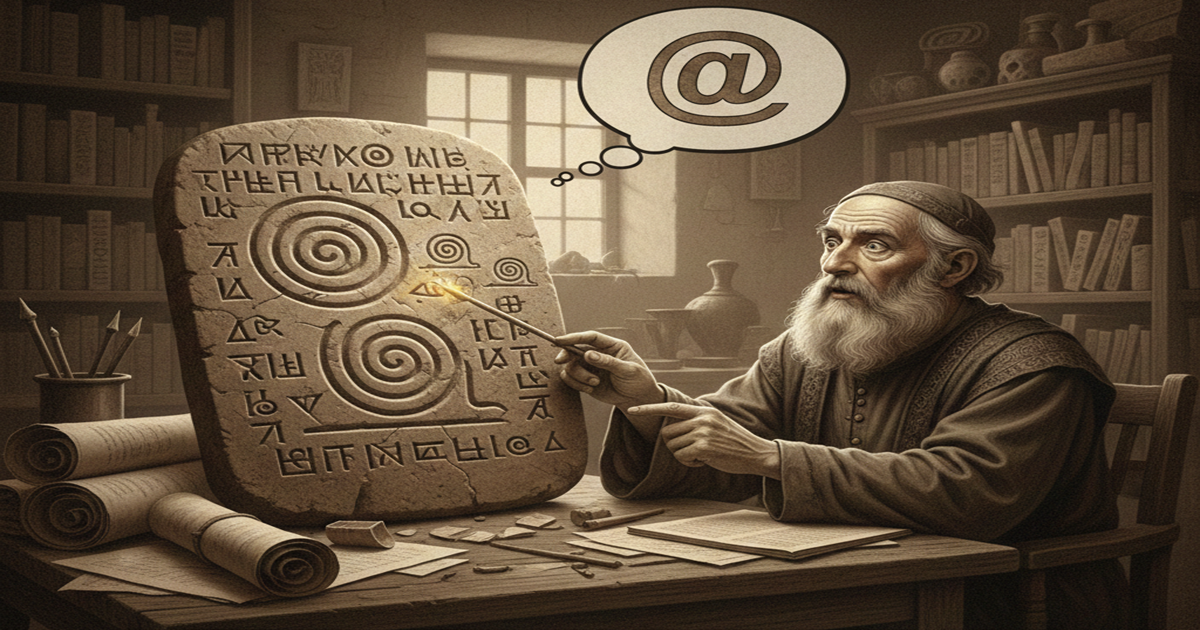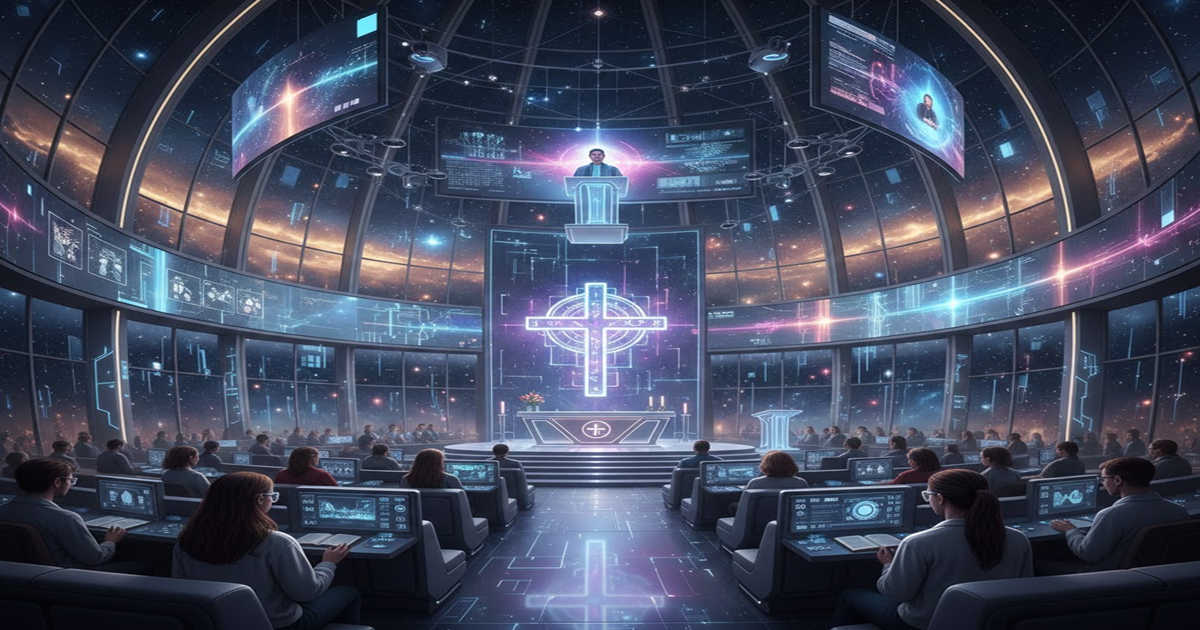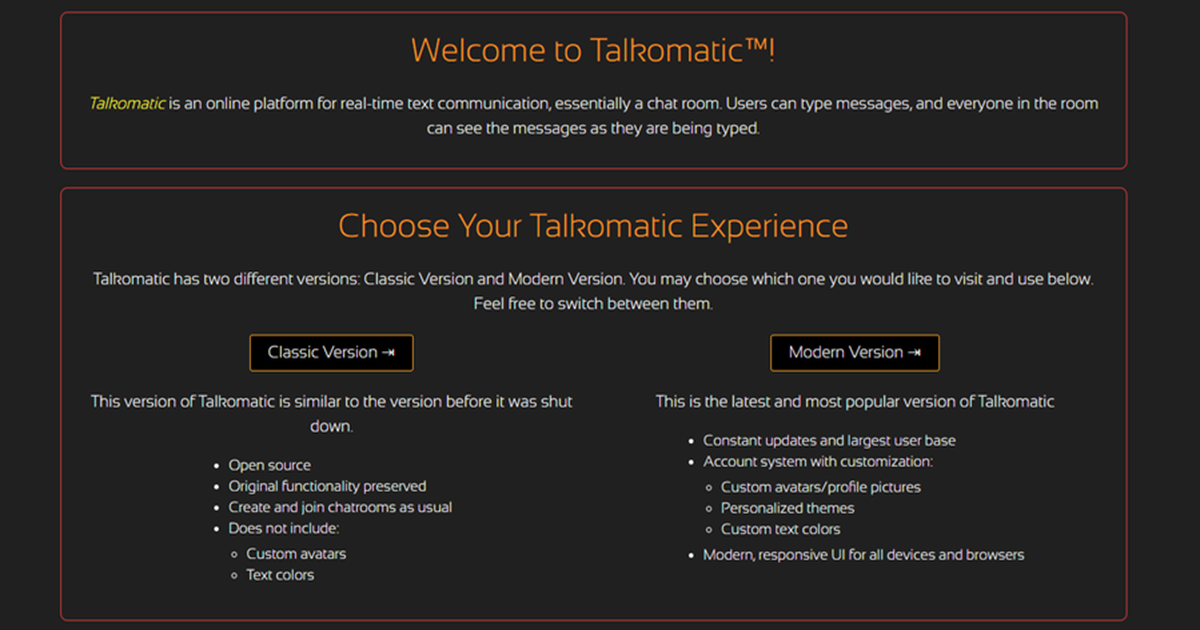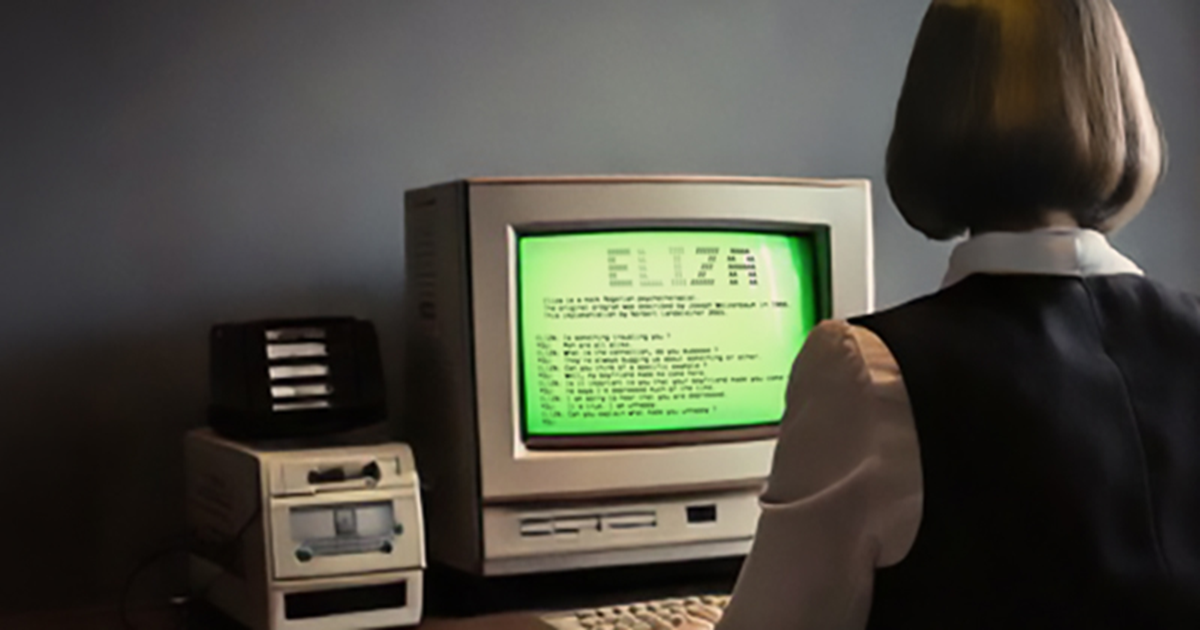Instagram: gli hashtag bannati nel 2022

Cosa comporta l’utilizzo di hashtag vietati e perché Instagram attua questa limitazione
Quando un hashtag viene utilizzato in maniera impropria da un certo numero di profili, nel cervellone di Instagram scatta un campanello d’allarme e tra le azioni che potrebbe intraprendere la piattaforma c’è anche quella di mettere al bando determinati collegamenti ipertestuali.
L’uso di hashtag bannati può avere conseguenze catastrofiche per il tuo profilo; in questo articolo ti spiegherò come riconoscerli, perché Instagram adotta questo provvedimento e in che modo dovresti usare questi strumenti per ottimizzare le performance del tuo profilo.
Come scoprire se un hashtag è bannato
Poiché questo strumento è molto utile per targetizzare i contenuti e generare engagement, molti profili cercano di sfruttarlo il più possibile, spesso ricorrendo a metodi non proprio graditi alla piattaforma. Nel caso non l’avessi ancora capito, mi riferisco ai bot, ovvero quei sistemi automatizzati esterni a Instagram che riempiono di spam i feed e le sezioni hashtag ed esplora.
Instagram non vede di buon occhio le intrusioni, specie se interferiscono con il funzionamento del suo algoritmo. Ecco perché il team della piattaforma di proprietà di Meta provvede periodicamente a setacciare gli hashtag nel tentativo di bloccare quelli sospetti. Dal momento che l’utilizzo di un hashtag bannato comporta l’oscuramento del contenuto o limitazioni del profilo, è importante essere in grado di riconoscere quelli non graditi da Instagram.
Si tratta di una procedura piuttosto semplice: prima di creare un contenuto, effettua una ricerca degli hashtag che vorresti inserire. Per farlo non devi fare altro che cliccare sull’icona a forma di lente nella dashboard della app e digitare nella barra di ricerca in alto il tag desiderato. A questo punto seleziona la scheda hashtag e verifica che il collegamento che cerchi compaia tra i risultati. Instagram ti mostra l’hashtag che hai in mente di inserire? Nessun problema.
Se però non lo fa significa che è stato bannato; pertanto, a prescindere dal fatto che si tratti di un ban definitivo o temporaneo, evita di utilizzare quell’hashtag perché questa decisione comporterà l’oscuramento del tuo post o della tua storia. E questo accade non solo nella sezione hashtag relativa a quel tag specifico, ma anche nelle sezioni degli altri hashtag presenti nel contenuto e nella sezione Esplora.
Quali sono gli hashtag bannati nel 2022
Poiché Instagram banna molti hashtag in via provvisoria, magari per un giorno o una settimana, è davvero difficile avere accesso a una lista sempre aggiornata di quelli inutilizzabili. Una cosa è certa: non sarà mai la piattaforma a comunicarli. L’obiettivo del ban, infatti, è tagliare fuori i bot poiché la loro attività peggiora l’esperienza utente e va contro l’interesse di Instagram, ovvero creare engagement e far sì che gli utenti trascorrano molto tempo al suo interno, cosa che non accadrebbe se il social venisse invaso da contenuti fuorvianti e pubblicità indesiderate.
Gli Instagrammer più attenti, però, a furia di pubblicare contenuti e fare ricerche sugli hashtag sanno bene quali risultano bannati in pianta stabile. Ecco perché è possibile pubblicare una lista di quelli che faresti bene a non usare mai nei tuoi post.
Qui sotto troverai un breve elenco (rigorosamente in ordine alfabetico) dei principali hashtag che nel 2022 presenziano stabilmente nella lista nera di Instagram:
- A: #abcess #abdl #addmysc #adultlife #adulting #alone #always #americangirl #attractive #assday #ass #assworship #africanexpeditions #allbreasts #asiangirl;
- B: #beautyblogger #beautydirectory #besties #brain #babe #bbc #bikinibody #books #beyonce;
- C: #costumes #cpr #curvy #curvygirls;
- D: #date #dating #desk #direct #dm;
- E: #easter #eggplant #elevator;
- F: #fishnets #fitnessgirls #followforfollow;
- G: #girlsonly #gloves #goddess;
- H: #hardworkpaysoff #happythanksgiving #hotweather #humpday #hustler;
- I: #ig #ilovemyinstagram #instasport #instamood #instababy #iphonegraphy #italiano;
- K #kansas #kickoff #killingit #kissing;
- L #l4l #leaves #lingerie #like #likeback #likeforlike #livinforalivin #loseweight;
- M #master #milf #mileycyrus #mirrorphoto #models #mustfollow;
- N #nasty #newyearsday;
- O #overnight #orderweedonline #outdoorbirth;
- P #parties #petite #popular #pornfood #prettygirl #pushups #publicrelations;
- Q #qatar #quadveins;
- R #rate #ravens;
- S #samelove #selfharm #skateboarding #skype #snap #snapchat #single #singlelife #stranger #saltwater #shower #shit #sallyhansen #sopretty #sunbathing #streetphoto #stud #swole #snowstorm;
- T #tanlines #teens #tgif #todayimwearing #treasurethesemoments #teen #thought #tag4like #tagsforlikes;
- U #undies;
- V #valentinesday;
- W #woman #womancrushwednesday #women #workflow #wtf;
- X #xanax #xxx #xenociteclad;
- Y #yochale #youngmodel.
Quali hashtag usare su Instagram nel 2022
Se un hashtag che avevi in mente di utilizzare per i tuoi post è presente nella lista, ovviamente non dovrai disturbarti per fare una ricerca. È probabile, però, che nel momento in cui sceglierai gli hashtag liberi da ban da inserire nei tuoi contenuti opterai per quelli più popolari. Ora, io capisco che la tentazione di usare i tag che vanno per la maggiore possa essere forte, ma poiché il mio obiettivo è aiutarti a usare Instagram nel migliore dei modi mi permetto di darti un consiglio: limitati a usarne giusto qualcuno. Non intasare il tuo post o la tua storia di Hashtag con milioni di follower.
Contrariamente a quanto potresti pensare, infatti, operare in questo modo non ti farà avere più visualizzazioni. E sai perché? Entrerai in competizione con un numero spropositato di contenuti. Dunque, a meno che tu non sia la Nike, la Ferrero o la Samsung, è difficile che questi hashtag ti regalino reach. Certo, la quantità di persone che li seguono ingolosisce, ma per crescere su questo social devi avere pazienza e lavorare sodo. Pertanto ti suggerisco di inserire due o tre hashtag popolari e riservare lo spazio rimanente a tag meno generici (dunque con meno follower) ma più di nicchia. In questo modo potrai giocarti le tue carte in uno spazio in cui c’è meno competizione e in cui un contenuto accattivante, interessante e utile avrà maggiori probabilità di essere visto.
In conclusione
La gestione di un profilo aziendale Instagram, e in generale di tutti i social network, richiede molta attenzione poiché basta inserire accidentalmente un hashtag vietato per mandare a monte una strategia di marketing. Al di là di tutto, però, oltre a rimanere vigili su certi aspetti, per gestire al meglio i propri profili social occorrono pianificazione, definizione degli obiettivi e regolarità nelle pubblicazioni.
© 𝗯𝘆 𝗔𝗻𝘁𝗼𝗻𝗲𝗹𝗹𝗼 𝗖𝗮𝗺𝗶𝗹𝗼𝘁𝘁𝗼
Tutti i diritti riservati | All rights reserved
Informazioni Legali
I testi, le informazioni e gli altri dati pubblicati in questo sito nonché i link ad altri siti presenti sul web hanno esclusivamente scopo informativo e non assumono alcun carattere di ufficialità.
Non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori od omissioni di qualsiasi tipo e per qualunque tipo di danno diretto, indiretto o accidentale derivante dalla lettura o dall'impiego delle informazioni pubblicate, o di qualsiasi forma di contenuto presente nel sito o per l'accesso o l'uso del materiale contenuto in altri siti.