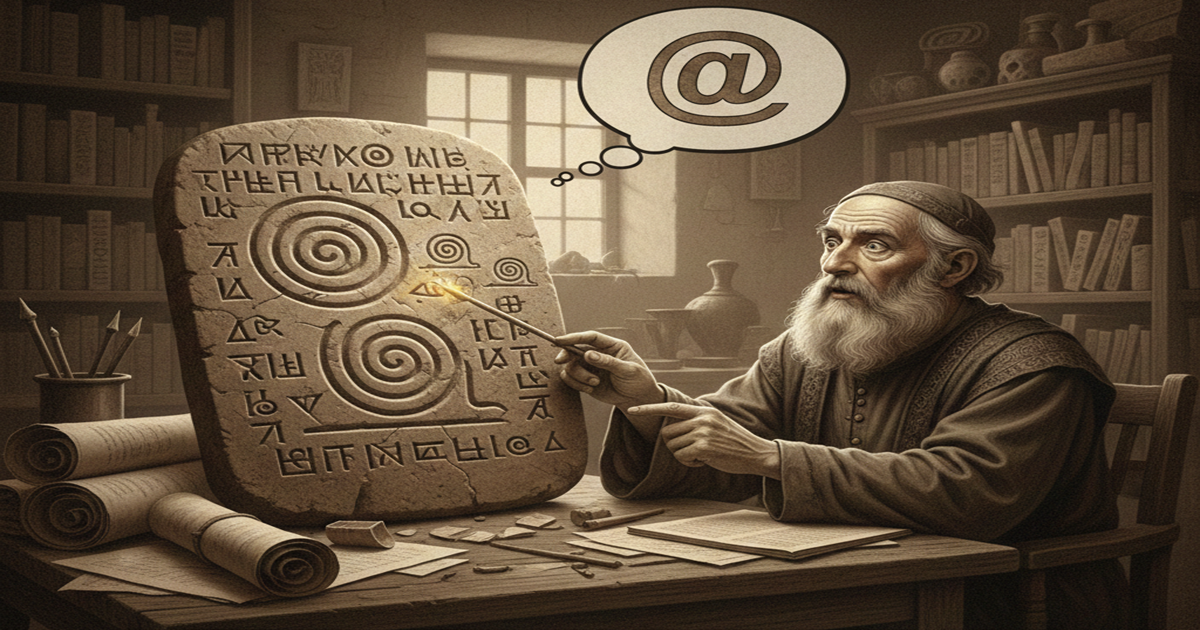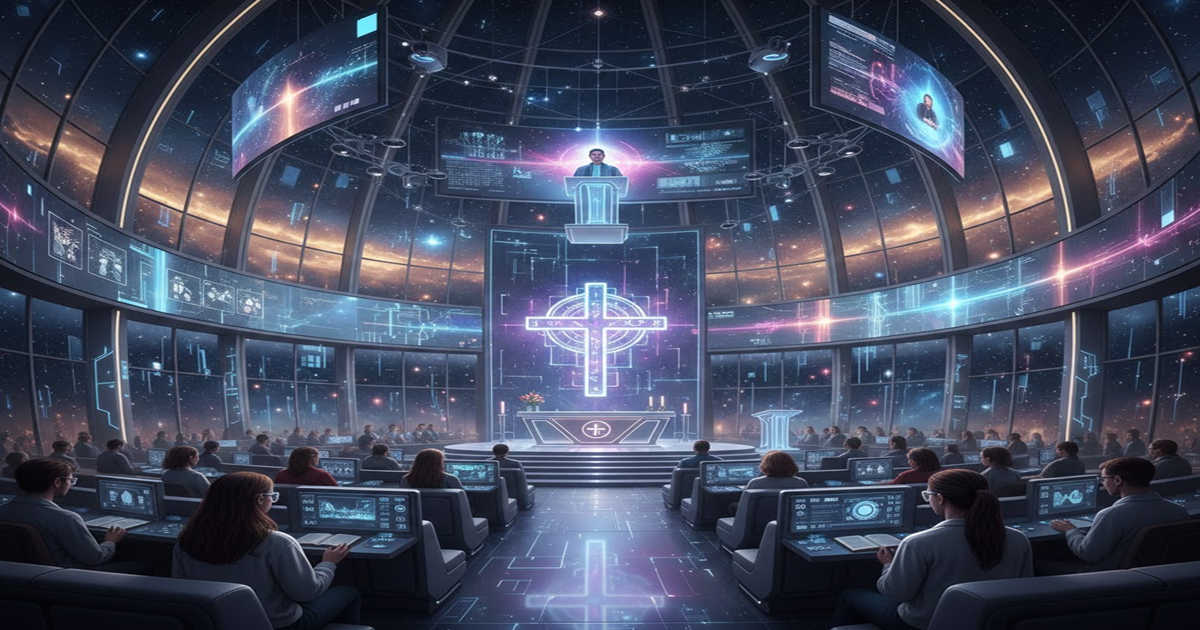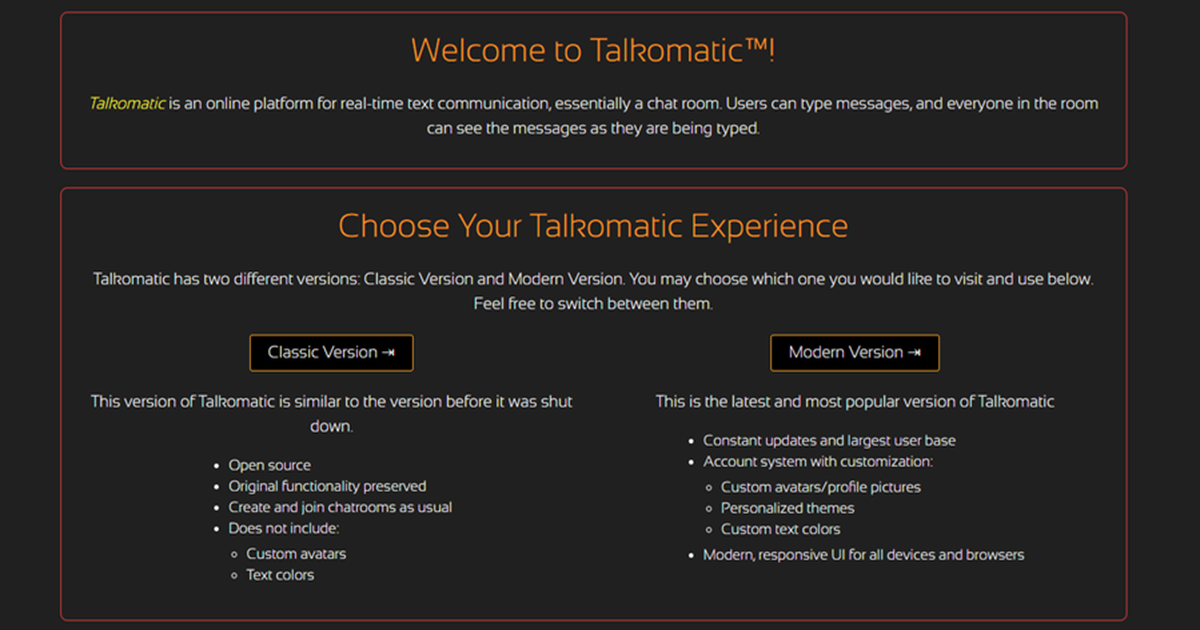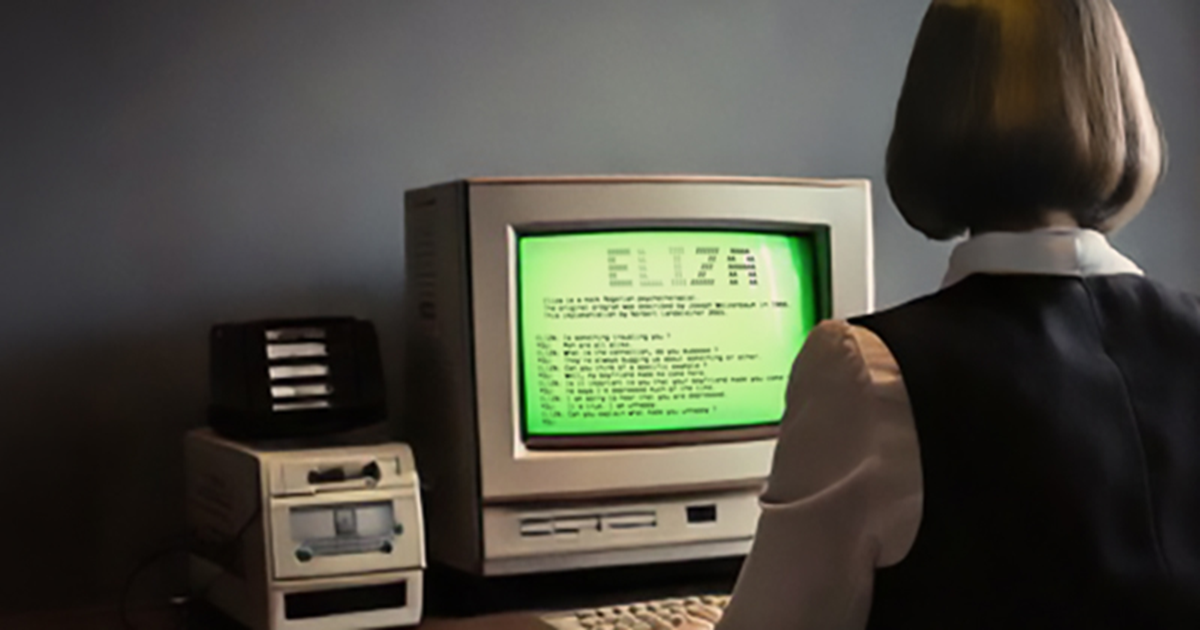Verifica dell’età online: il paradosso europeo tra tutela dei minori e fine dell’anonimato

In nome della protezione dei minori, l’Unione Europea sta spingendo verso nuove misure per la verifica dell’età online. L’obiettivo dichiarato: impedire l’accesso dei minori a contenuti inappropriati, come pornografia, gioco d’azzardo e violenza esplicita. Ma dietro questa nobile causa si cela un paradosso inquietante: per tutelare i giovani, si rischia di eliminare l’anonimato per tutti gli altri.
Le proposte legislative — contenute in diverse iniziative, tra cui l’European Digital Services Act e le raccomandazioni per una “Internet più sicura per i bambini” — impongono ai fornitori di contenuti di verificare in modo “efficace” l’età degli utenti. Fin qui, tutto comprensibile. Ma cosa significa davvero “verifica efficace”? E soprattutto, chi controlla e conserva i dati?
Dati sensibili in cambio di accesso
Per verificare l’età, le opzioni sono poche e tutte invasive: documenti d’identità, riconoscimento facciale, collegamento a servizi bancari. Sistemi che implicano l’identificazione personale dell’utente, anche per accedere a contenuti del tutto leciti per un adulto. È il prezzo da pagare, dicono i legislatori, per proteggere i più giovani.
Tuttavia, molte voci critiche — da attivisti digitali a esperti di privacy — lanciano l’allarme: così facendo, si demolisce uno dei pilastri fondamentali della libertà su Internet, ovvero l’anonimato. “Per evitare che un dodicenne acceda a un sito vietato, si finisce per schedare ogni trentenne che guarda un film vietato ai minori di 18 anni”, sintetizza un analista del think tank europeo EDRi (European Digital Rights).
Sorveglianza mascherata?
C'è chi teme che dietro la spinta alla protezione dei minori si nasconda un’ulteriore opportunità per la raccolta e il controllo dei dati personali. L’identificazione obbligatoria rende ogni navigazione tracciabile, ogni preferenza profilabile, ogni scelta potenzialmente analizzabile da governi o aziende.
“Un sistema che chiede di mostrare il passaporto digitale ogni volta che si apre un sito è incompatibile con una rete libera e democratica”, avverte Mozilla Foundation. “La tutela dei bambini non può essere usata come cavallo di Troia per introdurre una sorveglianza di massa.”
La sfida dell’equilibrio
Il paradosso si fa evidente: per proteggere una minoranza vulnerabile si impone un controllo pervasivo sulla maggioranza innocente. La sfida politica e tecnologica sarà trovare un equilibrio: sistemi che garantiscano una verifica dell’età robusta, ma che non compromettano i diritti digitali di tutti.
Soluzioni innovative — come i cosiddetti “verificatori fidati” o l’utilizzo di tecnologie zero-knowledge proof, che permettono di dimostrare l’età senza rivelare l’identità — sono già sul tavolo. Ma hanno ancora un cammino lungo da percorrere prima di essere adottate su larga scala.
Una questione di principio
In definitiva, la questione va oltre la tecnica e tocca i valori fondanti dell’Europa digitale. Vogliamo un’Internet che protegga i minori o una che sorvegli gli adulti? O, più semplicemente, è possibile costruire una rete che faccia entrambe le cose, senza compromettere libertà e diritti?
La risposta non è facile. Ma in un momento in cui la linea tra sicurezza e controllo si fa sempre più sottile, sarà fondamentale vigilare affinché la protezione non diventi censura, e l’identificazione non diventi schedatura.
© 𝗯𝘆 𝗔𝗻𝘁𝗼𝗻𝗲𝗹𝗹𝗼 𝗖𝗮𝗺𝗶𝗹𝗼𝘁𝘁𝗼
Tutti i diritti riservati | All rights reserved
Informazioni Legali
I testi, le informazioni e gli altri dati pubblicati in questo sito nonché i link ad altri siti presenti sul web hanno esclusivamente scopo informativo e non assumono alcun carattere di ufficialità.
Non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori od omissioni di qualsiasi tipo e per qualunque tipo di danno diretto, indiretto o accidentale derivante dalla lettura o dall'impiego delle informazioni pubblicate, o di qualsiasi forma di contenuto presente nel sito o per l'accesso o l'uso del materiale contenuto in altri siti.